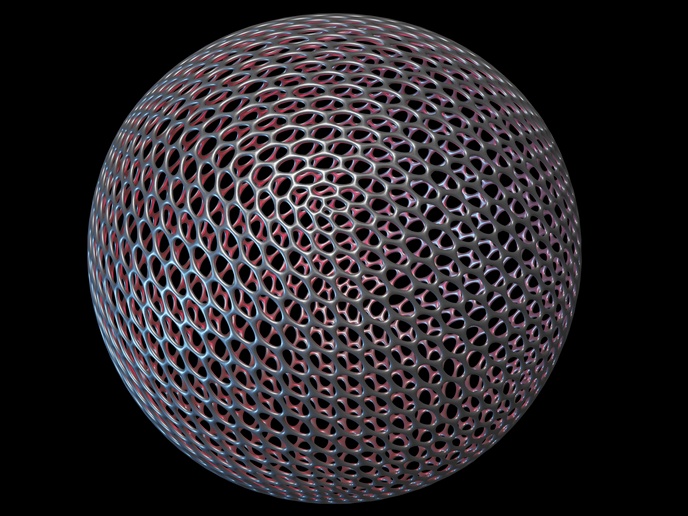Stimare i livelli di esposizione umana alle nanoplastiche
Le nanoplastiche, ovvero frammenti o particelle di plastica estremamente piccoli che possono finire nell’ambiente, sono diventate oggetto di numerose ricerche accademiche; gran parte di questo lavoro, tuttavia, tende a concentrarsi sul loro potenziale impatto sugli ecosistemi, piuttosto che sui rischi che ne derivano per la salute umana. Il progetto PLASTICHEAL(si apre in una nuova finestra), finanziato dall’UE, è stato lanciato per colmare questo squilibrio. «Siamo partiti con l’obiettivo di comprendere meglio ciò che ci accade», spiega Alba Hernández, coordinatrice del progetto PLASTICHEAL e ricercatrice presso l’Università Autonoma di Barcellona(si apre in una nuova finestra) (UAB), in Spagna.
Tecniche intese a identificare le nanoparticelle negli esseri umani
Il progetto si prefiggeva due obiettivi distinti: ottenere un quadro più chiaro dei livelli di esposizione umana alle nanoplastiche, un primo passo fondamentale per comprendere la portata del problema, e comprendere in maniera migliore i potenziali impatti che determinati livelli di esposizione potrebbero innescare sulla salute. Hernández osserva che, per quanto concerne la valutazione dei livelli di esposizione umana, è stato fondamentale tenere conto delle dimensioni delle nanoparticelle. «Solo le nanoplastiche più piccole sono in grado di passare dall’aria o dal cibo all’organismo e al flusso sanguigno», spiega la ricercatrice. «Da lì, quindi possono essere distribuite e accumularsi negli organi.» Il progetto ha sviluppato nuove tecnologie per identificare queste nanoplastiche negli alimenti e nelle bevande, nonché nell’aria, e per rilevarle nel sangue e nelle urine; inoltre, ha analizzato i lavoratori attivi nell’industria della plastica, i soggetti che ha ritenuto più esposti alle nanoplastiche. «Nessuno prima d’ora era riuscito a raggiungere questo obiettivo per particelle di plastica di dimensioni inferiori a un micrometro», aggiunge Hernández. «In tal modo siamo riusciti a comprendere meglio i livelli di concentrazione all’interno del corpo.»
Potenziali effetti delle nanoplastiche nell’organismo
Successivamente, sono stati sviluppati strumenti in vitro per esaminare i potenziali effetti generati dalle nanoplastiche sull’organismo. «Volevamo scoprire cosa succede quando la plastica entra nelle cellule e se questo genera stress, cambiamenti nel DNA o risposte infiammatorie, ecc.», spiega Hernández. «Intendevamo inoltre verificare la possibilità di prevedere gli effetti a lungo termine, compresa la cancerogenicità, e valutare eventuali cambiamenti nel microbioma.» A tal fine, il progetto ha sviluppato nanoparticelle il più possibile rappresentative di quelle presenti in natura con l’obiettivo di garantire che i risultati fossero il più possibile accurati. «Abbiamo ottenuto informazioni che riteniamo sufficientemente preoccupanti», osserva Hernández. «Tuttavia, c’è ancora molto da capire e non siamo tuttora a conoscenza di quali siano i limiti di sicurezza.»
Sviluppo e armonizzazione delle tecnologie analitiche
Il consorzio sta attualmente preparando una nuova proposta che darà continuità a questo lavoro basandosi sulle conoscenze acquisite e sulle tecnologie sviluppate. «Oggi sappiamo molto più di prima», afferma Hernández. I prossimi passi comprendono un ulteriore sviluppo e armonizzazione delle tecnologie analitiche. «Esse devono essere utilizzabili non solo all’interno del nostro gruppo di progetto, ma dall’intera comunità scientifica», aggiunge Hernández. «Dobbiamo discutere i vari protocolli con gli enti di standardizzazione.» Durante il progetto è stato messo in atto un grande sforzo per coinvolgere l’industria e le autorità di regolamentazione, in modo da garantire che i dati raccolti fossero il più possibile utili alla società. La finalità ultima, osserva Hernández, è che in tal modo sia possibile valutare accuratamente il rischio e regolamentare i limiti di sicurezza.