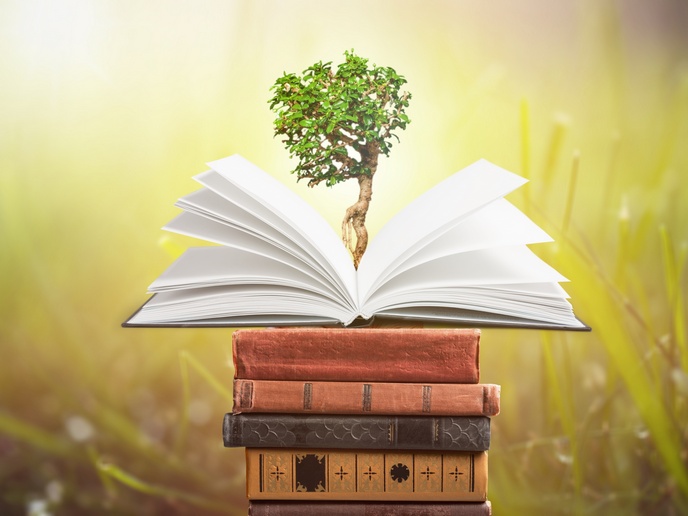La storia dell’estinzione di massa dal punto di vista degli ecosistemi
I ricercatori oggi hanno una conoscenza completa delle cause, dei meccanismi e del periodo storico delle estinzioni di massa, e i documenti fossili rivelano molte informazioni sugli effetti di questi eventi sulle specie terrestri e oceaniche. Ma secondo Davide Foffa(si apre in una nuova finestra) dell'Università di Birmingham, che ospita il progetto, è meno chiaro come la perdita di specie ha influenzato gli assemblaggi effettivi di strutture e composizioni ecologiche. «Quali ruoli, o nicchie, ecologici sono maggiormente interessati dalle estinzioni di massa? Dopo un’estinzione, gli ecosistemi tornano all’equilibrio e alla composizione precedenti o se ne creano di nuovi?», si chiede Foffa, ricercatore Marie-Curie(si apre in una nuova finestra) del progetto ECODIV(si apre in una nuova finestra). Per rispondere a queste domande, ECODIV si è proposto di raccontare la storia dell’estinzione di massa del Permiano-Triassico(si apre in una nuova finestra) da un punto di vista ecologico. Gli studi precedenti su questo tema avevano concentrato l’attenzione sull’impatto degli eventi di estinzione sulla vita globale, durante determinati intervalli di tempo (spesso ampi), ma ECODIV ha studiato invece come gli assemblaggi reali regionali/locali hanno attraversato le fasi di estinzione e recupero. «Ci interessava capire come gli ecosistemi collassano e come poi la biodiversità si rigenera, al di là dei calcoli sulla perdita e sul guadagno di specie», aggiunge Foffa.
Colmare il divario tra ecologia e paleontologia
ECODIV si è concentrato sull’estinzione di massa del Permiano-Triassico, in quanto fu l’estinzione più grave, e dalle conseguenze potenzialmente più significative, nella storia della vita sulla Terra, durante la quale si estinse fino al 70 % dei vertebrati terrestri(si apre in una nuova finestra). L’ampiezza dell’evento ha permesso di produrre un’ampia varietà di dati. Foffa ha applicato i moderni metodi dell’ecologia della conservazione per comprendere gli effetti della perdita, dell’aumento e della distribuzione delle specie. Nell’ecologia delle piante e degli invertebrati, le caratteristiche di ogni specie, come le dimensioni, la dieta, la riproduzione, lo stile di vita, l’habitat e la locomozione, descrivono il suo ruolo ecologico nell’ecosistema. «Tuttavia, questo approccio non è stato tipicamente applicato alla paleontologia dei vertebrati, che ovviamente manca di osservazioni dirette utili a comprendere il comportamento delle specie estinte», spiega Foffa. Grazie ai molti campioni di documentazione fossile di tetrapodi a livello mondiale dell’intervallo Permiano-Triassico, ECODIV ha descritto statisticamente le caratteristiche dell’assemblaggio di ogni specie (in base alle sue proprietà ecologiche), seguendone i cambiamenti nel tempo. ECODIV ha concentrato l’attenzione principalmente sul recupero e sulla diversificazione degli assemblaggi di tetrapodi nel sud-ovest degli Stati Uniti dopo l’estinzione di massa del Permiano-Triassico, un periodo in cui sono comparsi e si sono diversificati molti nuovi gruppi di rettili. Partecipando alle spedizioni del partner del progetto Virginia Tech(si apre in una nuova finestra) in Arizona, New Mexico e Texas, Foffa ha contribuito a colmare le lacune nella documentazione fossile, grazie all’esame di intervalli di tempo e aree geografiche con un minor numero di fossili, documentando nuovi assemblaggi di fossili del medio e tardo Triassico.
Comprendere meglio i cambiamenti ambientali a lungo termine
Sebbene i nuovi assemblaggi terrestri (soprattutto quelli che preservano le specie con un corpo di piccole dimensioni) siano ancora in fase di analisi, è già emerso che l’evoluzione di questi nuovi gruppi ha introdotto nuovi ruoli e opportunità ecologiche. «Abbiamo visto che le strutture ecologiche cambiano nel tempo, parallelamente alla comparsa e alla scomparsa di gruppi animali. Ad esempio, i ruoli dei predatori apicali e degli erbivori negli ecosistemi permiani differiscono da quelli del Triassico, quando sono comparsi e si sono diversificati nuovi gruppi», spiega Foffa. Anche la ripresa dell’ecosistema alle basse latitudini è stata probabilmente lenta, stabilizzandosi solo 20-30 milioni di anni dopo l’evento di estinzione, poiché la composizione della fauna ha continuato a cambiare fino al tardo Triassico. Ciò significa che le faune e le strutture ecologiche si sono stabilizzate solo nella seconda parte del Tardo Triassico. Foffa sta continuando ad analizzare l’enorme quantità e qualità dei dati fossili raccolti, confrontando i modelli di estinzione e recupero tra i diversi ecosistemi a livello globale. «Stiamo traendo grandi benefici dalla combinazione di tecniche paleontologiche tradizionali, come il lavoro sul campo, con tecnologie e metodi moderni, come la TAC e i modelli ecologici», afferma Foffa.